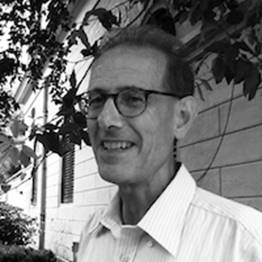|
Te n’eri già
volato via, da qualche parte sulle tue montagne, quel giorno di due anni fa quando
venni a trovarti in ospedale. Un’amica mi indicò la stanza, e con un groppo
in gola entrai, temendo di pentirmi, ma non mi pentii – perché non eri lì.
Fredda e lucida razionalità affermerebbe che la malattia ti aveva
trasfigurato – perché sembravi un’altra persona – ma la realtà “vera” è che
tu non eri lì. Me ne andai, strano
a dirsi, rassicurato – eri da qualche parte nel mondo e questo mi confortava
(lo ha fatto fino a pochi giorni fa) ma non eri in quel letto d’ospedale.
Semplicemente, in modo piano ed ovvio, quel posto non t’apparteneva. Perché tu eri
proprio un’altra cosa. Ti ho conosciuto circa quindici anni fa, ero appena
arrivato a Pavia e mi sorprese e suscitò immediata simpatia quel sorridente
professore dall’aria assente e i capelli spettinati, occhiali grandi, fisico
asciutto (o dovrei dire, ascetico?), lievemente curvo, segno inequivocabile
dell’abitudine a trascorrere lunghe ore chino sui libri – certamente su
formule ed equazioni, era evidente. E perennemente, che fosse estate o inverno,
vestito nello stesso modo: come i professori d’una volta, camicia, giacca e
cravatta, gli orli delle maniche con qualche traccia di gesso – ineffabile
strumento di sapere con cui tracciavi geroglifici matematici inaccessibili
agli studenti (ma eri buono come il pane, e gli studenti ti adoravano – ben
lungi dall’incarnare lo stereotipo del matematico lunare e misantropo).
Riguardo alla tua camicia-giacca-cravatta ti prendevo in giro, suggerendo che
sotto quei due strati di tessuto non ci fosse la pelle come per gli esseri
umani comuni, ma che fossero essi stessi la tua pelle, e che tu vivessi
semplicemente con la tua cute di cotone e stoffa e naturalmente ci andassi a
dormire (perché mettere uno strato di cotone in più come il pigiama? Sto
benissimo così), e ridevo immaginandoti sotto le lenzuola sempre “in” giacca
e cravatta, come una specie di supereroe della matematica e dell’astrazione.
Perché con te
si poteva scherzare come si scherza tra ragazzi, e non ho visto mai, in tutti
questi anni, altro atteggiamento in te se non una perfetta, completa umiltà.
Nemmeno un atomo – “un quanto” forse avresti detto tu – di presunzione,
un’altra cosa che non ti apparteneva, come quel letto d’ospedale. In te
impressionava e meravigliava l’abissale discrepanza tra il tuo sapere –
immenso ed articolato, e l’innata timidezza, pacatezza, tipica di chi teme di
essere smentito (quando invece quasi sempre chi ne sapeva di più eri tu).
Eliano non smettere mai di visitare la mia mente ed essermi di esempio,
perché esattamente così dovrebbe essere uno scienziato: curioso,
intelligente, severo con se stesso e con le proprie
equazioni, ma umile ed onesto con i colleghi – ed eri buono, in quel modo
semplice e piano e naturale, non perché si debba essere buoni ma perché era
lo stato intrinseco della tua mente, su cui non aveva senso alcuno porsi
domande. Anni fa lessi Primo Levi che raccontava commosso dell’amico Lorenzo
Perrone, un muratore piemontese che lavorava ad Auschwitz e salvò la vita al
chimico italiano. Levi scrisse che Lorenzo lo salvò non tanto e non solo
perché gli portò di nascosto una gamella di zuppa ogni giorno per sei mesi
(rischiando ogni volta la sua, di vita) ma perché gli ricordava costantemente
che esistesse un modo giusto e buono di essere uomini, al di fuori di quell’orribile
mondo di negazione in cui si era trovato precipitato. Ecco Eliano, io non ti
ho conosciuto molto bene, ma quella era la mia impressione di te, e vorrei
che tu continuassi a ricordarmi sempre qual è il modo giusto e buono di
essere, e di fare il nostro mestiere.
Eliano sorride mentre mia figlia gli devasta le
equazioni sulla lavagna Sull’umiltà e
sull’essere ancora, dopotutto, un ragazzo (nonostante camicia-giacca-cravatta
intrinseche) racconto un episodio. Un giorno vidi risme di carta stampata
tutta su un solo lato, e leggendone gli argomenti – fisica quantistica – non
fu difficile inferire che si trattava di cose tue. Venni nel tuo studio e ti
“sgridai” – tra il serio e il faceto, per non aver stampato fronte e retro.
Tu ti scusasti a profusione, spiegando che eri abituato a prendere note sul
retro del foglio, e che non eri mai riuscito ad abbandonare questa tua
pessima abitudine. Eri sinceramente imbarazzato. Fu difficile convincerti che
il mio commento era stato scherzoso, che si, era giusto stampare fronte-retro
ove possibile ma che io lo avevo detto nel modo giocoso e goliardico che si
usa tra amici – ma tu in quel momento eri un ragazzo sgridato dal suo
professore. Che assurdità,
questo contrasto – io professore tuo! I paradossi suscitati dalla tua
proverbiale umiltà. Qui nasce il mio peggior rimpianto: non essere stato tuo
studente e non aver mai assistito – maledetto me – ad una tua lezione.
L’universale simpatia – adorazione – che riscuotevi tra tutti i tuoi
studenti, e il profluvio di aneddoti divertenti (esilarante un’imitazione
della tua parlata, con il caratteristico accento laziale) mi avevano sempre
incuriosito, ma non sono mai venuto ad una tua lezione, perché ti conoscevo
abbastanza da pensare che forse – ridicolo a dirsi, ma penso di non essere
andato lontano dal vero – ti saresti sentito imbarazzato a vedermi tra il
pubblico. Eliano, mi
confortava sapere che tu ci fossi ancora. In modo strano ed assurdo, ma
queste sono parole di affetto e tenerezza, non della razionalità che era il
tuo mestiere – il fatto che tu, seppur in un letto d’ospedale fossi ancora
tra noi mi dava pace ed una quieta, lontana sicurezza. Che peccato non aver
parlato di più, non averti preso in giro di più, nel modo bonario che
accettavi col tuo sorriso scanzonato, non averti frequentato, non aver saputo
più cose di te. Quante cose matematiche avremmo discusso, quanti racconti
tibetani ed esotici, quante lavagne e quanto gesso sulle maniche. Ma cosa
posso fare? Immaginarti volare sulle tue crode chissà dove, ora che la tua
densità è quella giusta perché tutto sommato di nuvole sei sempre stato fatto
ed è lì che galleggiava la tua mente sotto i capelli arruffati e quel sorriso
di anima generosa e mite.
Alessio Toraldo – 25 marzo 2020
Credo che tutti abbiano sperimentato almeno una volta nella vita quella fastidiosa sensazione di non ricordare il testo di una canzone o di una poesia che un tempo si sapeva a memoria. Quando mio figlio aveva poche settimane, ho scoperto di ricordare una ninnananna in dialetto veneto che la mia bisnonna mi cantava da piccola. All’inizio erano solo poche parole, alla fine sono riuscita a ricostruirla tutta! Sapevo che era lì da qualche parte: me l’aveva insegnato il caro professor Pessa 15 anni fa. Un giorno a lezione raccontò questo aneddoto. Non ricordo il contesto, ma posso presumere che intendesse dimostrarci che certi ricordi sono lì, da qualche parte, anche se non lo sappiamo, ma se ci mettiamo d’impegno, con pazienza, riusciremo a ricostruirli. L’aneddoto riguardava una filastrocca o una canzoncina che aveva imparato da piccolo e di cui ricordava solo pochi frammenti. Insomma, un giorno, mentre stava scalando, era rimasto bloccato nella sua tenda a causa di un’improvvista tempesta di neve. Con la paura di non superare quel pericolo, era rimasto praticamente “intrappolato” per ore e ore che aveva pensato bene di dedicare al recupero di ogni singolo verso della canzoncina. Mi pare che ci avesse impiegato tutta la notte, ma alla fine ce l’aveva fatta e, ovviamente, era anche sopravvissuto alla tempesta. Grazie professore – non avrò bisogno di impegnarmi molto, invece, per ricordare il suo sorriso gigante e l’entusiasmo contagioso che portava in classe.
Valeria Bellan – 6 aprile 2020
Le parole così belle di Alessio regalano una splendida descrizione del Professor Pessa; una descrizione vera ed autentica, esattamente come è stato il Professore. Queste parole mi incoraggiano a condividere la mia esperienza di incontro con questa figura così emblematica per il dipartimento, per gli studenti e gli accademici, per me. Un incontro che si è snodato in tutte le fasi della mia vita universitaria pavese.
|